Clara Jourdan (a cura di)
Intervista a Luisa Muraro
Da Miopia n.32, settembre 1998, numero monotematico LE FIGLIE, IFIGLI.
(Il disegno è elaborato dalle illustrazioni originali dell'articolo).
Incontro con Luisa Muraro di una classe V di studentesse dell’Istituto Tecnico Sperimentale Statale per il Turismo e Linguistico “Artemisia Gentileschi” di Milano.
L’incontro è avvenuto su richiesta delle studentesse dopo che avevamo visto insieme una trasmissione televisiva della serie “Tema. Domande di fine millennio” in cui la domanda discussa da Luisa Muraro e Patrizia Di Pietro era “Il potere sarà al femminile?” (Rai 3, 2 marzo 1998, ore 11). Luisa Muraro ha accettato volentieri di venire a scuola, e abbiamo fissato l’incontro per l’8 giugno.
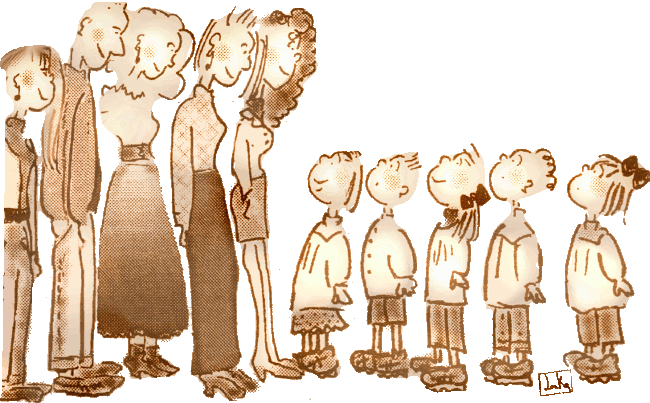
In preparazione, ho dato da leggere l’intervista “La presenza femminile negli scenari sociali” (a cura di Lucia Bianco, “Animazione sociale”, dicembre 1996). Le ragazze avevano già letto, due anni fa, i racconti storici “Salti di gioia” (in “Femminismo”, Stampa Alternativa, Roma 1996), e sapevano che una frase della filosofa era stata data come traccia per la prova scritta di italiano all’esame di maturità linguistica l’anno precedente.
L’incontro è avvenuto tranquillamente, con molta attenzione, silenzio e pochi interventi (le mie colleghe dicono che è una classe passiva, io invece dico che è riflessiva, e con loro si può approfondire).
C. J.
[...]
Luisa Muraro: Come tipo di scuola, adesso che siete alla fine, vi piace, o c’è qualcuna che ha dei pentimenti, per esempio?
Mara: Io sì (e comincia una discussione in cui alcune criticano l’insegnamento delle lingue ricevuto: avrebbero preferito imparare più linguaggio pratico che letteratura).
Luisa Muraro: Io non la penso come te. Per me come si dice dentifricio o come si indica la strada si impara da soli, non c’è bisogno di fare scuola per queste cose semplici. Io penso che le conoscenze umanistiche - che vuol dire la letteratura - siano un guadagno umano tuo, che ti mette in condizione di avere più coscienza di te, più intelligenza delle cose del mondo. Perché i grandi scrittori, le grandi scrittrici sono persone che hanno pensato molto profondamente le cose, anche le cose quotidiane, che noi magari ci passiamo sopra: l’amore, la morte, l’odio, l’invidia. Loro ci entrano in profondità, anche le poetesse, i poeti lo fanno. Allora, imparare a conoscere queste cose fa sì che tu sei un essere umano più ricco. Dopo, le cose pratiche le puoi imparare tu.
[...]
Tra voi vi capita di litigare? (“Siii”). E lo fate tra voi o riuscite a farlo come un’attività scolastica, cioè scoppia una discussione e poi durante la lezione...
Mara: Anche se stiamo parlando con la professoressa di un argomento di attualità o qualsiasi altra cosa, se iniziamo a discutere discutiamo.
Luisa Muraro: E le prof favoriscono, sì?
Mara: Non sempre.
Luisa Muraro: Quali sono i temi su cui discutete, con discussione polemica? Sono questioni di amori, affetti, gelosie, o di idee?
Voci: di affetti... anche di idee... delusioni... anche di invidia... c’è molta competizione...
Clara J.: Io non lo avverto questo.
Luisa Muraro: Loro sono più sensibili di noi, anche all’università accennano molto alle persone più arriviste, che vogliono mettersi in mostra. Io non noto nulla. A me pare anzi il contrario.
Arianna: Forse anche perché noi viviamo in un ambiente diverso dall’università, da quello che ci dicono. Noi abbiamo l’obbligo di frequenza, praticamente stiamo insieme sempre, abbiamo i cambi dell’ora, gli intervalli... Io penso che quando andrò all’università avrò un rapporto diverso, tipo “ho perso gli appunti, me li puoi prestare?”.
Luisa Muraro: La tua osservazione è molto giusta, e hai fatto bene a ricordarmelo. Ti segnalo che all’università ti capiterà una cosa spiacevole, non priva di rimedi, che è il contrario, e cioè che non riuscirai più a fare amicizia. La situazione così fluida e movimentata farà sì che tu non avrai più questi legami che hai avuto qui. Nel mio corso gli unici che ho visto avere legami fra loro venivano dalla stessa classe della scuola media, a Verona; gli altri erano disgregati. Pensate che ho preso l’abitudine di andare qualche volta al bar con le mie studentesse e studenti perché facessero amicizia. Tu dici “ho perso gli appunti, prestameli!”: c’è una competitività di altro tipo per cui neanche ti aiutano. Comunque, tra la situazione vostra e quella dell’università, c’è pure una via di mezzo. Voi siete vincolate a orari, a compagnia, a materie... tutto tutto tutto è regolamentato; siete tenute nella situazione identica dei bambini e delle bambine di prima elementare.
Mara: L’unica libertà che abbiamo è di entrare e uscire senza darci la manina...
Elena: Nell’intervista ad “Animazione sociale”, lei accennava alla politica prima dicendo che è “fare tessitura sociale”: potrebbe approfondire?
Rita: La mia tesina riguarda i bambini nella seconda guerra mondiale. La prof Jourdan mi aveva dato Salti di gioia con il racconto “Collaborazionista”, e vorrei sentire altri ricordi. (Espone la bibliografia della sua tesina).
Luisa Muraro: Tra voi ci sono altre che hanno interesse per i bambini o hanno interesse per ricordare se stesse bambine? (Tante dicono di sì). E siete orientate a diventare madri? Oppure vi piacciono indipendentemente? No. Siete orientate quindi alla maternità. E la vostra infanzia ve la ricordate? Un poco.
Simona: Io odio ricordare il passato.
Luisa Muraro: Anche Lia è una che ricorda pochissimo. Poi ti parlerò di questa nostra amica, Lia Cigarini, di quello che mi racconta della sua infanzia. Lei è figlia di uno che era nella resistenza, un comunista, quindi era nella resistenza dagli inizi, mentre mio padre era entrato tardi. Suo padre era già ricercato dal tribunale speciale ancora prima, quindi per lei la guerra è stata più difficile che per me. A te non piace ricordare?
Simona: Non mi piace ricordare com’ero. Mi sembra che ero stupida.
Luisa Muraro: Cioè il cambiamento giovanile ti ha marcato come una rottura. D’altra parte per voi di anno in anno il cambiamento è forte.
Corinne: A me capita spesso di stare da sola e ricordo. Vivo dei miei ricordi.
Simona: Io no. A me piace pensare al presente.
Luisa Muraro: E’ come Lia Cigarini. A me piace riandare alla storia del sequestro di Aldo Moro, ecc...: “son cose passate” dice, è molto proiettata sul presente e futuro. Come se la facoltà della memoria fosse meno sviluppata. Io invece sono come lei che dice che vive dei suoi ricordi, a me piace tantissimo ricordare. Ho un cassetto pieno di fotografie.
Sabrina: Io ho avuto delle esperienze molto brutte. Ma a me piace ricordare solo le cose belle. E quando ci ripenso trovo sempre una cosa bella della cosa brutta.
Luisa Muraro: A voi piacerebbe andare in televisione a parlare, come facevano quelle studentesse nel programma, o come facevo io? (No.) Nessuna di voi ha voglia di andare a lavorare in televisione.
Mara: A far la valletta no.
Luisa Muraro: Certamente. Infatti mi sono riferita a quelle studentesse e a me che facevamo un’altra cosa: ragionare in maniera chiara, per esporre delle idee... Avere un ruolo pubblico, un’immagine pubblica, per esempio le giornaliste Rai? E tu che vuoi andare all’università, che cosa vuoi studiare?
Arianna: Medicina veterinaria.
Luisa Muraro: Chi ancora vuol andare all’università? Tu che cosa vorresti studiare?
Annalisa: Psicologia.
Altre voci: Pubbliche relazioni. Scienza delle comunicazioni.
Luisa Muraro: Allora, le vostre preferenze e scelte di studio si riferiscono proprio a quello che domandava Elena, la politica prima che è tessitura sociale. Voi, spontaneamente, ma non tanto, perché è la società anche che ispira certe esigenze, certe inclinazioni, molte di voi - non lei che vuole fare medicina veterinaria, che è una professione legata a una competenza scientifica - tutte le altre, per le cose che avete espresso, vanno proprio nel senso di lavorare nella tessitura sociale. Voi volete farne un lavoro, invece che farne una politica, ma le due cose sono vicine. Questa è una società che è cambiata tanto, voi non ve ne rendete conto perché siete venute dentro il cambiamento, e ci siete dentro. Fino a trenta-quarant’anni fa, era una società patriarcale con un ordine molto preciso, stabilito, una gerarchia adulti-bambini, uomini-donne... Gerarchia vuol dire ordine sacro: c’erano le regole morali, l’aborto era peccato, fare l’amore se non si è sposati era peccato, se una ragazza non sta chiusa e protetta i maschi sono autorizzati a trattarla con poco rispetto... Era una società patriarcale a economia mista industriale-agricola, ma ancora con una forte presenza della cultura contadina, anche dentro alle città. Poi questa società per varie ragioni si è tutta modificata, quindi è una società che rischia la disgregazione, e da ciò viene che nascono diversi lavori per fare tessitura sociale: è proprio una necessità di specialisti della tessitura sociale, e voi siete orientate a farlo. La cosa curiosa è che le donne tradizionalmente nella vecchia società patriarcale questo facevano, spontaneamente: chiacchieravano molto, mettevano in giro le notizie, facevano anche i pettegolezzi critici, facevano la critica dei comportamenti che non andavano bene, però si aiutavano fra loro, c’erano gli aborti clandestini, c’era tutta una serie di cose che le donne facevano per fare tessitura sociale, per aiutarsi, sì, tra loro, ma per tenere insieme la società. E non a caso voi che siete le figlie, le nipoti delle donne che facevano questo spontaneamente, voi vi orientate a fare questo. Secondo gli esperti di cose del lavoro, le donne avrebbero una capacità superiore agli uomini nel fare tessitura sociale, nella comunicazione con gli altri. Sarebbe una specie di di più femminile.
[...]
Luisa Muraro: [...] Io sono nata proprio nei giorni in cui l’Italia entrava in guerra, nel giugno del 1940 (la guerra era già scoppiata nel ’39, come sapete), quindi per me era tutto normale, io credevo che il mondo fosse fatto con gli aerei che venivano a bombardare, e di notte a volte bisognava andare a dormire nei rifugi. Tutti i giorni gli aerei degli alleati bombardavano la linea ferroviaria (sono nata nel nord dell’Italia, c’era l’occupazione tedesca). Venivano anche i caccia. I bombardieri stavano alti e bombardavano, si vedeva proprio che cadevano le bombe, i caccia scendevano molto bassi, a pochi metri dal suolo, in picchiata, e tutto quello che si muoveva mitragliavano; una volta un povero signore che aveva il suo carretto tirato da un cavallo è rimasto ammazzato. Come lo vedete al cinema. Mi ricordo una volta che la contraerea ha abbattuto un caccia americano o inglese, siamo andati noi bambini a vedere: l’uomo era andato tutto in briciole, e noi in mezzo a guardare il macello di questo aereo schiantato nei campi vicini. Per me era tutto naturale. Finché mia mamma è rimasta calma, io sono rimasta calma. Perché per i bambini piccoli è un altro ordine simbolico. Io non ho ricordi terribili, anche se ho ricordi di tutte queste cose qui, spaventose in sé, ma non per me. Per esempio avevano impiccato per rappresaglia dieci uomini nel castello del nostro paese; poi è esplosa la scuola elementare (nel sotterraneo i partigiani tenevano molte armi e polvere da sparo, fumando hanno fatto saltare tutto, in piena notte). Per la mia amica Lia è stato diverso, perché lei doveva vivere con un cognome diverso. Ha dovuto andare a scuola con un cognome falso, e doveva dire il cognome falso. Glielo avevano insegnato, ma è una cosa che l’ha molto turbata, lei capiva che non partecipava della normalità degli altri. Le suore facevano da copertura, tenevano la bambina col nome falso perché il padre era ricercato dalla polizia politica fascista. Lei dice che questa angoscia di dire il nome falso la teneva preoccupata tutto il tempo, non riusciva a imparare niente, non riusciva a concentrarsi per questo turbamento simbolico. Per dire la potenza dei fatti simbolici. Come se il suo fosse un nome di cui vergognarsi, un nome maledetto, un nome pericoloso. Tutte queste cose le sentiva in una maniera che non riusciva a districare. E poi c’è l’altro fatto: durante la guerra sua madre ha voluto collaborare con la lotta armata e faceva la staffetta, ha lasciato i bambini a una donna di servizio che era sempre piena di paura e quindi questa donna ha riempito anche lei di paura. Mentre mia madre era per me una sicurezza di riferimento, invece questa donna buona, piena di buona volontà ma spaventata - perché sapeva che aveva in mano dei bambini di un ricercato e doveva dire anche lei un nome falso, e si sentiva schiacciata da questa responsabilità - le ha passato la paura. Quindi per lei sono tutti ricordi terribili, confusi, tanto che poi ha dovuto fare la psicanalisi, anche per ritrovare i ricordi della sua infanzia.
Claudia: Lei ha detto che si vede donna perché sua madre la vede così. Io non mi vedo come mi vede mia madre.
Luisa Muraro: Guarda, io faccio il lavoro della filosofia, che è di pensare a fondo alle cose. Ma sarebbe lo stesso se tu facessi la poetessa o la scrittrice, questi lavori del pensiero creativo, che vuol dire che non è che impari quello che hanno già pensato altri e basta, ma che tu ti metti al compito di ripensare le cose. La realtà ha bisogno che pensiamo di nuovo. Per farlo c’è bisogno di tutte le risorse dell’interiorità fino all’inconscio: ci scendo con le mie emozioni, la mia salute, i miei sogni di notte. Se non posso scendere in profondità perché ho qualcosa di sbarrato, non ho più creatività del pensiero.
Claudia: Io desidero autonomia.
Luisa Muraro: Anch’io. Sono andata via di casa a diciotto anni, con il consenso dei miei genitori, allora si diventava maggiorenni a ventun anni. Ho cercato di tenere insieme le due cose. Anzi penso che sia indispensabile tenerle insieme, la massima autonomia personale rispetto alle proiezioni degli adulti, e la massima fedeltà profonda. Io ho cominciato a quindici-sedici anni a pensare con la mia testa. E poi ho voluto essere autonoma anche nel muovermi. Però c’è anche il fatto della fedeltà all’infanzia. Quando dico la madre, io penso la relazione materna, che vuol dire che cosa ero io quando amavo mia madre. Non si tratta che adesso devo amare mia madre come quando avevo un anno, due anni. Ma quando avevo un anno, due anni, io con mia madre ero in simbiosi, io formavo una entità amorosa con lei di un genere che forse nei massimi innamoramenti si riesce a ritrovare da adulti. Allora io voglio ritrovare quelle emozioni là. Le voglio ritrovare non per essere legata, per essere libera. Ho scritto un libro su queste cose, che si intitola L’ordine simbolico della madre. Poi ho ascoltato quello che le donne mi dicevano, che è un po’ simile a quello che tu mi stai dicendo (è stata Rosetta Stella che mi ha fatto la critica su quel punto lì), cioè che il libro rischia di essere sentito come una imposizione di dovere, e quindi essere, come diceva lei, un meno di libertà.
Sabrina: Lei pensa che per ottenere la libertà bisogna proprio combattere? Ci sono persone che per raggiungere la libertà non prendono di petto la cosa, non fanno una rivolta, ma cercano un compromesso.
Luisa Muraro: Non basta combattere. Quelli che prendono di petto e fanno le rivolte una via l’altra a volte finiscono meno liberi di prima. Combattere sì, ma prima e insieme trovare una misura dentro di sé. Sapere cioè che cosa una vuole e quanto è disposta a dare per quello che vuole. Trovando questa misura si ha la tranquillità di combattere gli ostacoli che si frappongono. Il compromesso in certi casi è necessario accettarlo. Chi accetta un compromesso necessario non perde un ette di libertà. Ma anche lì occorre avere consapevolezza, chiedersi: è necessità questo compromesso?
